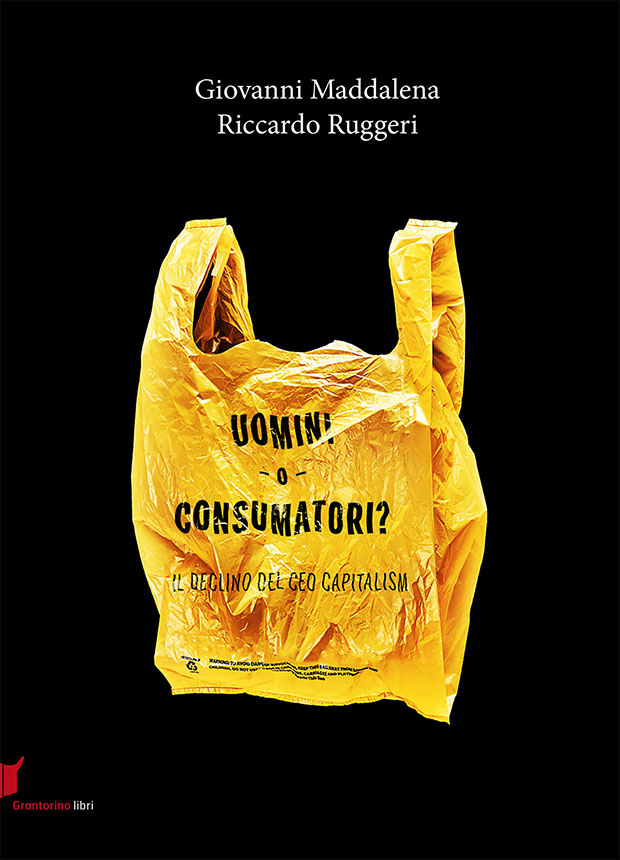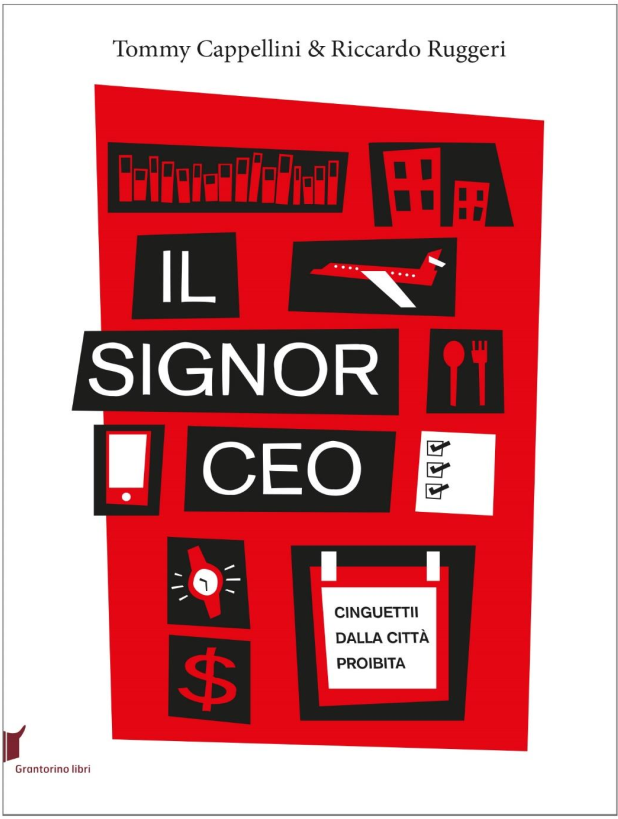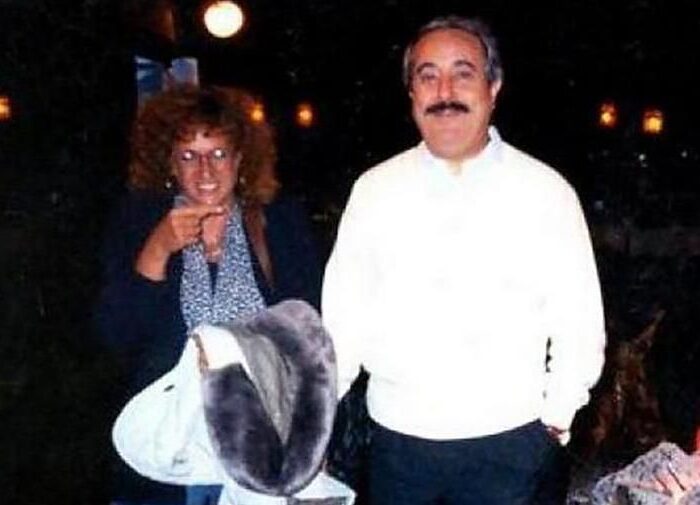E’ epoca di indici, intesi come indicatori di qualsiasi evento o processo umano. In genere danno informazioni sbagliate, spesso manipolatorie. Prendiamone uno a caso: gli occupati-disoccupati. Perché non prendere le “ore lavorate”, aggiungendo pure ferie-malattia, dividerle per 40 (ore settimanali) e sapremo finalmente quanti sono gli occupati effettivi in numero assoluto (sarà mica un numero sconvolgente?) e in percentuale sulla forza lavoro, indipendentemente che gli inoccupati siano o meno sfiduciati (è statistica, non sociologia). Ora basta lavorare un paio d’ore alla settimana per entrare nelle statistiche, ma rimanere nella più bieca povertà.
C’è un vecchio-nuovo indice “Misery index” i politicamente corretti insistono nel non tradurre, bovinamente, misery con “miseria” (la povertà fa orrore), neppure “disagio”, ci impongono “infelicità”. Costruirlo è semplice, basta sommare il tasso di disoccupazione (ahi ahi) e il tasso di inflazione (ahi) e voilà. Sono noti i dati del 2016: essendosi impegnato molto, il Venezuela di Nicolàs Maduro, 573, è maglia nera. Segue Brasile 75, Turchia 31, Grecia 28, Russia 27, Spagna 19, Italia 15, Francia 11, Uk 10, Usa 9, Austria 8, Germania 6, Svizzera e Cina 5 e primo assoluto il Giappone 0,4 (avete letto bene, 0,4).
Ho interpellato il mio amico banchiere svizzero, lui dice che questo indice si usa con riferimento alla sostenibilità del “rally azionario” (si intende un forte aumento dei titoli dopo un periodo di stasi, ovvero un incremento dei prezzi che riprende parte di una precedente ripresa, nda). Molte le teorie interpretative, una è come misurare la soglia di preoccupazione, l’atteggiamento degli investitori riguardo alle attese inflazionistiche. Cioè, se vi è timore di inflazione, gli aumenti dei tassi sono percepiti negativamente, ma se lo scenario è stabile il rally continua. Se, come ora, salgono le azioni insieme ai tassi, gli investitori temono la deflazione. Se invece si vendono le azioni si teme l’inflazione. Negli anni ’70 l’indice era sui massimi, le valutazioni del mercato erano basse, mentre ora la situazione è ribaltata, il mercato azionario può crescere ancora perché la buona occupazione stimola consumi e utili senza inflazione.
Sul dato del Giappone l’ho visto in difficoltà, non ho insistito. Per un decennio ho molto frequentato il Giappone, mi colpì la loro idiosincrasia verso due aspetti del vivere civile: il rifiuto assoluto verso i migranti e comprarsi comunque il loro il debito pubblico (guai però parlarne). Da anni leggo che tutti gli economisti del mondo insistono per invitarli ad aprire le frontiere, ma loro sono fermi nei propri convincimenti: nessun inquinamento culturale esterno, la priorità del paese è il pieno impiego, lavorino giovani, donne, vecchi a tempo pieno, niente lavoretti. Neppure quei pochi curdi che, per la convenzione di Ginevra, sono costretti a prendere, sono sì mantenuti dignitosamente, ma non autorizzati a lavorare fino a quando il lunghissimo iter autorizzativo sia finito. Il lavoro come stile di vita in Giappone coincide con la qualità della vita.
Il rapporto debito/pil è il più alto del mondo (220), eppure nelle tempeste finanziarie tutti si rifugiano nel franco svizzero e nello yen. Che vorrà dire? Speriamo solo che i “populisti” nostrani non facciano collegamenti strani sul misery index 0,4 del Giappone, sui migranti, sul debito, sullo yen moneta rifugio. Il primo che si presenta in un talk show dottoreggiando sul misery index sbanca.