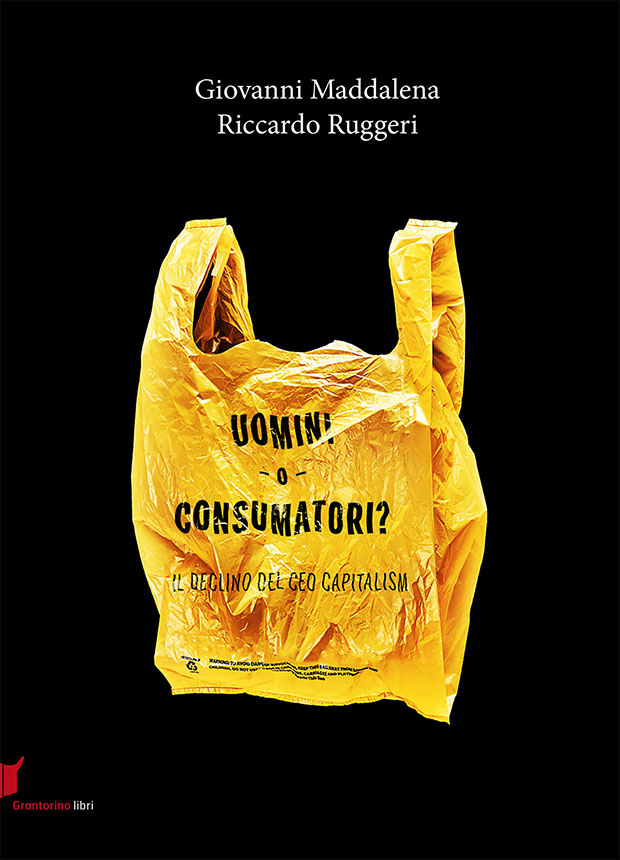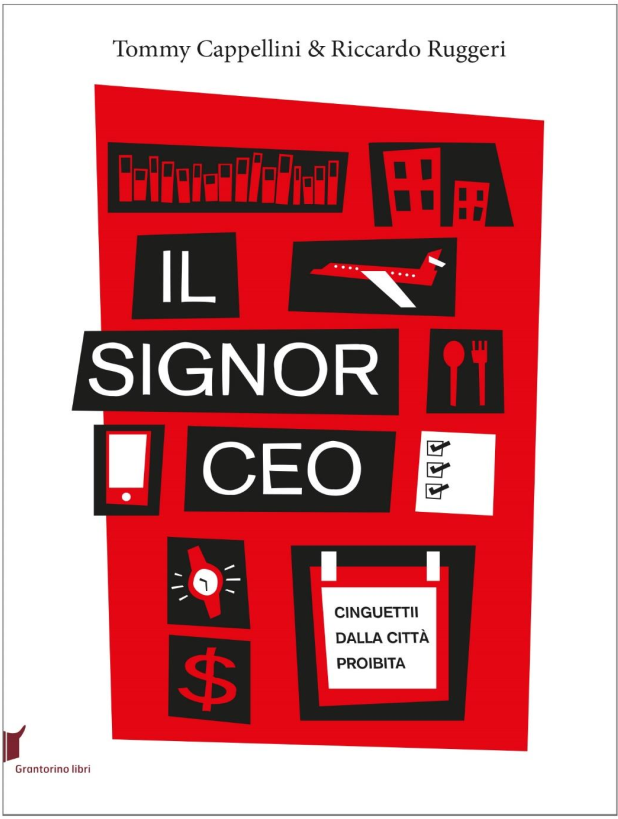Gli americani amano molto i loro Presidenti, anche per il doppio ruolo di Comandante in Capo, meglio, sono convinti che ciascuno di loro lo possa diventare, moltissimi i cittadini che, seriamente, sognano di entrare alla Casa Bianca. E quando ci entrano, sognano di rimanerci a vita, pur sapendo che non sarà possibile, mai. Entrano pimpanti, escono bolsi. Bastano otto anni per essere come prosciugati, rassomigliare sempre più a una tela, quella sulla quale il protocollo presidenziale prevede vengano ritratti: figurine Panini a olio, settecentesche. Su un punto ogni presidente non transige: vuole passare alla storia. Lo chiamano defining moment, il momento in cui un Presidente degli Stati Uniti entra, più o meno trionfante, nella storia. E’ anche il momento in cui gli storici lo valutano e lo classificano. Per George Washington defining moment fu la vigilia di Natale del 1776, quando attraversò il fiume Delaware. Per Franklin Delano Roosevelt, quando entrò in guerra contro le potenze dell’Asse. Per John Kennedy, quando lanciò da Berlino il monito “Ich bin ein Berliner” (io sono berlinese). Per Ronald Reagan, quando definì “evil empire” (impero del male) l’Unione Sovietica. Due parole talmente potenti che rappresentarono il primo atto del crollo dell’invincibile comunismo sovietico. L’ultimo quarto di secolo è stato un disastro, il degrado si è palesato anche alla Casa Bianca. Per Bill Clinton, il defining moment fu quando Monica Levinsky portò al procuratore Kenneth Starr il suo vestito orlato di seme presidenziale. Per George Bush, quando, convinto che la guerra in Iraq fosse finita, sulla portaerei Abramo Lincoln, disse “mission accomplished” (missione compiuta), con tanto di cartello di supporto. Per Barack Obama quando, dopo 100 giorni (sic!), riuscì a tappare l’uscita del greggio-metafora dal pozzo Macondo (BP) nel golfo del Messico. Per Donald Trump il defining moment si è già palesato, forse a sua insaputa. Non era un politico, non era un generale, non aveva un partito alle sue spalle, era considerato da tutti un “buzzurro”, eppure ha vinto, a furor di popolo. Attraverso una mossa a sorpresa della maggioranza silenziosa del popolo americano, guidato dal saggio Midwest agricolo e dalla mitica rust belt (la cintura della ruggine, gli Stati industriali che hanno fatto grande l’America), entrerà nella Stanza Ovale, potrà sedersi al resolute desk.
Il doveroso rinnovamento dei G7, dopo l’espulsione di David Cameron, il fine corsa di Barack Obama, proseguirà in modo crudele: nel 2017, sotto a chi tocca, François Hollande, Angela Merkel, ….. Il rinnovamento avviene, come giusto, nel modo più nobile e più brutale, con il voto, modalità Hillary-Donald. Il popolo, versione maggioranza silenziosa, abbatte con la scheda i suoi leader inetti, dopo che questi si erano illusi, grazie a sondaggi compiacenti, peggio ruffiani, e guru strapagati (la matematica applicata alla politica) che sarebbero rimasti al potere. L’elenco era già scritto: dopo Hillary, la mitica Michelle, quindi Bush junior, infine Chelsea Clinton, le figlie di Barack, e così all’infinito. Con Trump il giochino della strisciante, ma pianificata successione monarchica è morto. L’aspetto curioso è un altro, le élite occidentali per confermarsi al potere avevano escogitato il Partito della Nazione, un ircocervo che metteva insieme, in modo mascherato, Destra e Sinistra, mantenendo in essere un finto bipolarismo, al solo scopo di confermare al potere le caste-famiglie prescelte. Il popolo ha risposto con la maggioranza silenziosa, capace con un voto semplicemente contro, di abbattere il potenziale tiranno. La democrazia della scheda ha vinto contro gli apparati elitari? Calma e gesso, prima di cantare vittoria. La strada è lunga, i nemici potenti e scaltri.
Riccardo Ruggeri