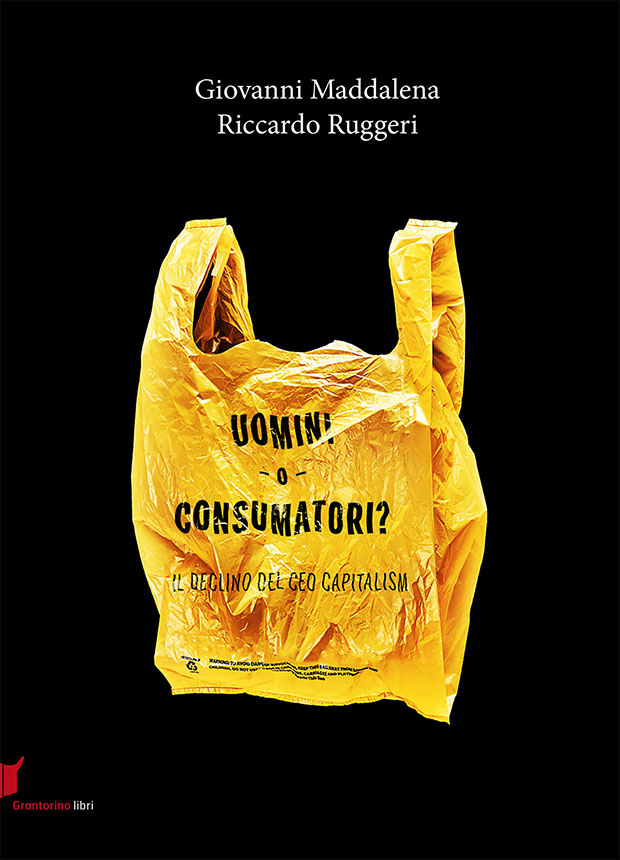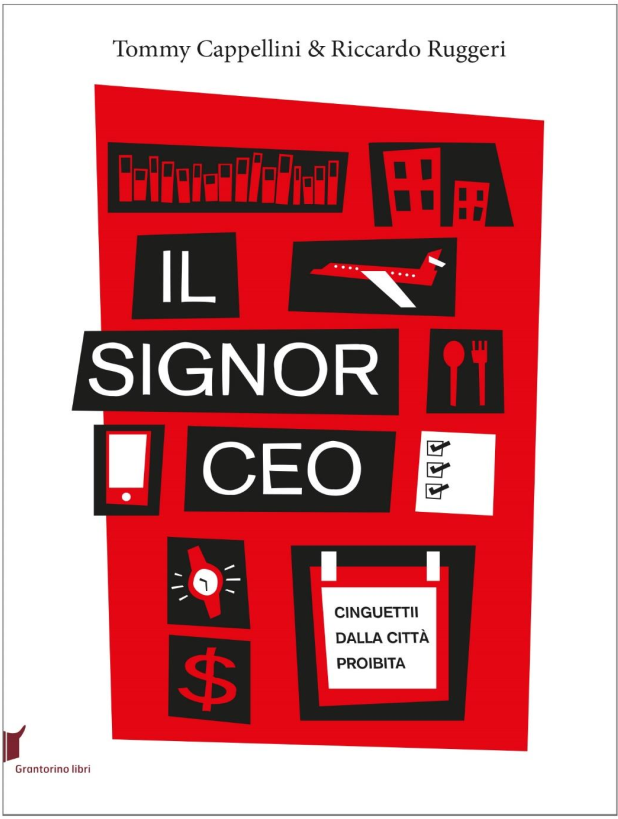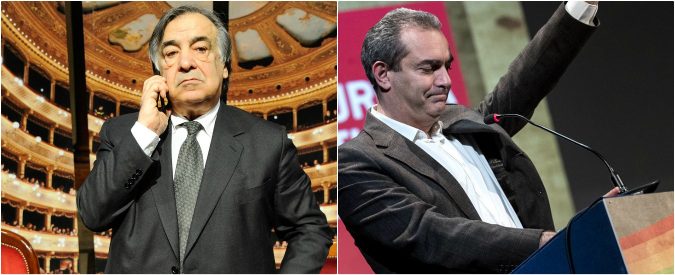Sono anni che faccio analisi e proiezioni per cercare di capire in che mondo vivranno i miei amati nipoti. Un progetto velleitario, di un vecchio signore che tante ne ha viste e tante vissute, cosciente della sostanziale idiozia dei suoi comportamenti in un’avventura, come questa, intellettualmente troppo grande per lui. Ma tant’è, ci lavoro da una decina d’anni, leggo e processo quantità industriali di documenti, libri, articoli, talk show. Godo del privilegio di essere esente da ogni ricatto e di agire dai miei interstizi svizzeri. I test li faccio in America, i «segnali deboli» li colgo ovunque.
Il fatto che nuore e figli gestiscano una multinazionale tascabile, presente nei tre scenari chiave del mondo (Europa, America, Asia, mercato del lusso), mi è utile per i segnali deboli che ricavo. Ogni settimana produco analisi e considerazioni per oltre 20.000 battute, ma non faccio alcun progresso nel disegno dello scenario. Da anni mi dico: sono convinto che la mia analisi sia credibile, però manca qualcosa, manca un evento esterno inatteso, forse il mitico cigno nero? Finora mi sono sempre nascosto dietro una locuzione fideistica: «Per superare questa situazione critica, qualcosa succederà, non so cosa, dove, quando, ma succederà». Dall’8 novembre 2016 mi chiedo: e se il cigno nero avesse il ciuffo rossiccio di Donald Trump? Non come leader, non ne ha la statura, ma forse come levatrice, come forcipe.
Primo insegnamento. Il modello nato un quarto di secolo fa dai calcinacci del Muro di Berlino fa acqua da tempo. I suoi presupposti (libero scambio, democrazia liberale, multilateralismo, multiculturalismo) appena hanno cessato di essere concetti (alti) e parole (nobili), appena si sono scontrati con l’execution, hanno fallito.
La globalizzazione, giusta o sbagliata che sia, non è più considerata un’opportunità, è tornata alla casella di partenza, quando era una minaccia. Le colpe vanno a identificarsi, anche in questo caso giusto o sbagliato che sia, con i leader coinvolti: Bill Clinton per averla promossa, George Bush per essersi associato supinamente, Barack Obama per averci messo la sua faccia, i suoi bei modi, il mitico «Yes we can», dimostrando al popolo americano che neppure dell’establishment moderato si può fidare.
La globalizzazione per sopravvivere richiede ora una cura da cavallo, con una priorità non negoziabile: il lavoro americano deve essere a capotavola. Punto. Quindi via la meschina «uberizzazione», via la meschina gig economy, basta la sudditanza dalle grandi corporation globalizzate, dalle piattaforme californiane. E le élite cuscute si consolino pure con i loro patrimoni, ma stiano, se non fuori dalle stanze del potere, almeno in piedi.
Secondo insegnamento. Si ripristini in fretta l’ascensore sociale, l’unica filosofia di vita che garantisce la meritocrazia, l’economia di mercato, l’imprenditoria, la crescita del popolo. Nessuna rivoluzione, solo un riequilibrio, nel rispetto dei valori fondanti dell’America.
Terzo insegnamento. Le elezioni hanno dimostrato che la furbata del Partito della Nazione (democratici e repubblicani che fingono di battersi ma hanno un’unica piattaforma programmatica) non funziona più, anche in America hanno scoperto il «’cca nisciuno è fesso». La risposta della maggioranza silenziosa americana è stata geniale, non puntare su un partito, su un movimento di opposizione, ma su un uomo solo, a volte con tratti orrendi, ma fuori dai giochi, non ricattabile (Clinton ha ricevuto dai soliti loschi finanziatori vagonate di dollari, Trump neppure un decimo).
Quarto insegnamento. Le élite, devono darsi una mossa, fare una spietata autocritica privata e pubblica, oppure hanno il destino segnato: saranno l’aristocrazia 1.0 pre rivoluzione francese, quella di Maria Antonietta, delle brioche.
Amici, svegliatevi! Ve lo dice uno che dell’élite è diventato parte: l’ascensore sociale l’ha portato fino all’attico grazie all’America della cintura della Bibbia e di quella della ruggine.