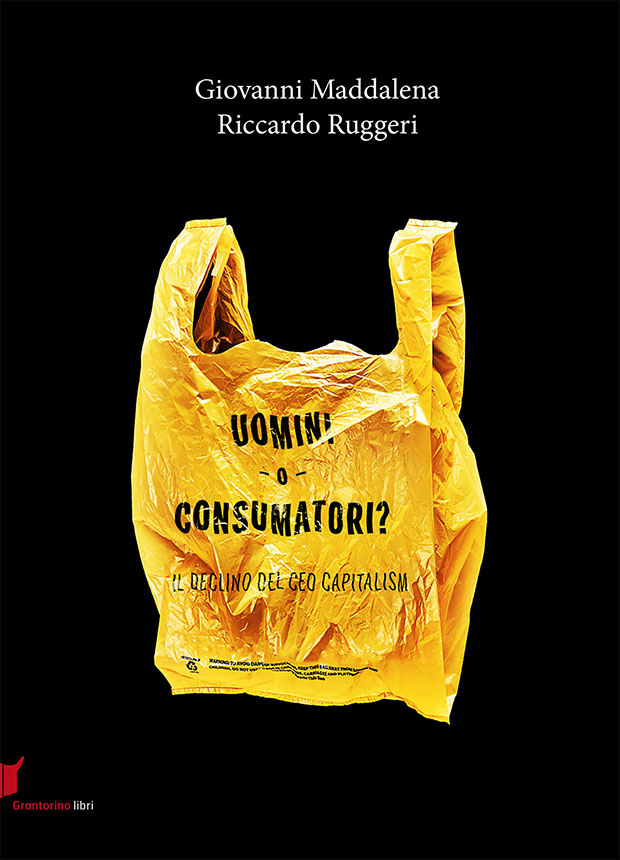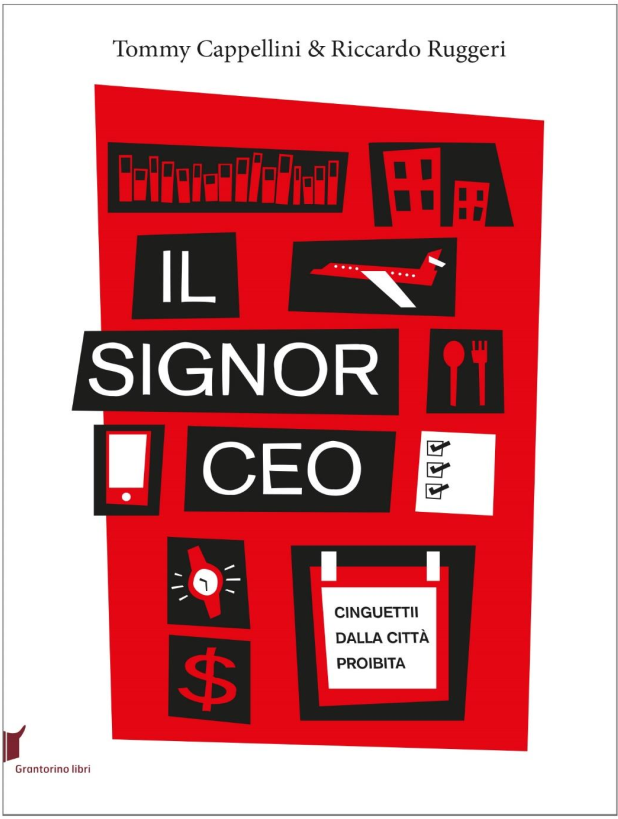Era un uomo inadeguato per gli anni in cui visse, perfetto per il mondo d’oggi: esigeva diritti, rifiutava doveri, parlava solo di sé, non valeva nulla ma voleva essere leader
Due le grandi fortune della mia vita: a) nascere povero; b) avere la prospettiva di morire magari benestante, due privilegi che in futuro non avrà più nessuno, le relative prospettive sono oggi invertite. Altro privilegio, essere vissuto, almeno fino alla pubertà, con i miei nonni (quelli paterni durante l’anno, quelli materni nei tre mesi estivi): erano contadini o operai, da loro imparai molto. Nel ramo materno, la nonna (dodici figli) era dell’Alta Garfagnana, nonno della Lunigiana, nel ramo paterno, nonna della Langa, nonno della Lunigiana. Tre quarti di sangue alto toscano, un quarto di alta Langa. Sangue contadino, quando ci trasferimmo in officina, si arricchì di ferro. Le due nonne e il nonno materno erano persone povere e perbene, allevati con valori cattolici o anarchici forti, mai li tradirono. Non così il nonno paterno, non perché avesse mai compiuto alcun reato, però campò mettendo al centro del mondo se stesso, fu uomo di egoismo smisurato. Ecco il motivo per cui l’ho scelto per questo ricordo, un uomo inadeguato per gli anni in cui visse, perfetto per il mondo d’oggi: esigeva diritti, rifiutava doveri, parlava solo di sé, non valeva nulla ma pretendeva, con arroganza, di essere il nostro leader, parlava, parlava, solo ovvietà e frasi fatte.
Sono nato povero e ho la prospettiva di morire benestante. Due privilegi che in futuro non avrà più nessuno
Un modello, il suo, che dopo la caduta del Muro diventerà vincente per i leader. Il bisnonno, il vertice del mio albero genealogico (oltre, non so nulla, solo il buio del Medioevo), non l’ho conosciuto, ho scoperto che rifiutò di fare il mezzadro (“mai servo”), preferì sempre “lavorare a giornata” (“il padrone me lo scelgo io, ogni giorno”, diceva), l’ho ammirato. Di lui mi resta un quaderno di sonetti (189 pagine, titolo “Sospiri del Bardo” 1876-1917), stabilì che alla sua morte passassero al primo maschio, ora l’ho io, presto lo darò all’unico nipote maschio, il piccolo Jacopo. Sono sonetti dedicati alla Madonna, ai Santi, agli amici, di un contadino anarchico che aveva rispetto, diceva, solo di Gesù e dell’Alighieri. Ecco come descrive la sua casa di Mochignano: “Son quattro mura, rozze, affumicate / due pancacce intorno al focolare / un tavolaccio per poter mangiare / un po’ di polenta e due patate / un paio di lenzuola stropicciate / su un pagliericcio per poter russare / di cimici e di pulci un alveare / di topi roditor cento brigate”. Una casa spartana, il cibo era vegano, era animalista suo malgrado, russava come solo i poveri sanno, era un poeta contadino che amava la vita, la chiesa, le donne, il vino (scrisse, e lo dimostrò, che non erano incompatibili). Purtroppo, Nonno Stalin da lui non prese nulla, sarà il nipote (mio papà) il suo vero figlio, in termini umani, etici, culturali. Appena cominciai a parlare (tardi, come tarda ebbi la pubertà, e sempre “ritardata” fu la mia vita da adulto, infatti ho cominciato a fare il mestiere che sognavo, il giornalista, a 75 anni) mi impose che lo chiamassi Nonno Stalin. Era alto, robusto, aveva mani sproporzionate, antifascista schedato (“i non schedati sono tutti fascisti”, diceva), una certa rassomiglianza con l’originale. Lui ne era orgoglioso, si pavoneggiava con tutti, anche con i fascisti, ripeteva fino alla noia la noia che Stalin in russo significa “acciaio”, e lui lavorava proprio all’altoforno 5, quello degli acciai speciali.
La mia famiglia, i miei nonni avevano sangue contadino.
Quando ci trasferimmo in officina, si arricchì di ferro
Nel portafoglio, usato solo la domenica pomeriggio, teneva una foto di Stalin in uniforme da ammiraglio. Si definiva marxista comunista, papà sosteneva che non conoscesse il significato delle due parole. Nonno Stalin era poco intelligente, ma aveva una grandissima considerazione di sé, una totale sicurezza, non supportata da nulla, e da niente scalfita. In questo, era un uomo non di una stagione eroica come quella degli anni Trenta e Quaranta, ma perfettamente coerente con i tempi attuali.
Alla cena della domenica, il momento più importante della nostra settimana, la nonna aggiungeva il riso al minestrone di ogni giorno, e solo per Nonno Stalin una cotenna di maiale (di cui si appropriava appena la pentola arrivava in tavola). Obbligava tutti a versare nel piatto parte del bicchiere di vino che aveva loro religiosamente elargito, dopo aver aperto “na buta stupa”, uscita dagli “infernotti” (cantina due piani sottoterra). Il momento peggiore era il fine cena, dovevamo sorbirci una filippica politica, in due atti. Il primo dedicato alle nefandezze del Duce (chiamato sempre Monssù Ceruti) e del Re (sciaboletta), il secondo a Stalin, per compiacere la Nonna, molto religiosa, ammiccava che Gesù era l’unico paragonabile a Stalin, ma si capiva che, da grande ruffiano quale era, mentiva. Aveva un moto di commozione sincero solo la prima domenica di settembre, quando ricordavamo la morte, a 19 anni, di zia Michelina (bionda ed eterea) avvenuta molti anni prima. La Nonna incolpava della morte l’umidità della portineria, le correnti d’aria dell’androne, che l’avevano portata alla tisi. Per un riflesso condizionato, malgrado l’età, temo tuttora le correnti d’aria, persino in spiaggia, quando spira il maestrale.
Se alla domenica il Toro giocava in casa, Nonno Stalin, papà e io andavamo al Filadelfia, la Nonna era felice. Quando invece giocava la Juve, Nonno Stalin mangiava in fretta, andava in cortile (dove avevamo il lavandino), si sbarbava, si insaponava, si detergeva l’ampio torace (era orgogliosissimo delle sue dimensioni), una nuvola di borotalco, due gocce di Floid sul viso, quindi indossava una delle sue bellissime camicie, metteva l’unica cravatta (granata, nodo scappino), uno dei due vestiti che possedeva, una delle tre paia di scarpe della domenica (marrone, nera, bicolore per l’estate: in punto di morte me le donò, raccomandandomi di tenerle “morbide”, perché erano di cuoio grasso). La vestizione era un momento di grande impegno per la Nonna (molti anni dopo in Andalusia assistetti alla vestizione di un celebre torero, non era molto diversa). Dopo l’uscita di Nonno Stalin, esausta, la Nonna cominciava a piangere in silenzio, solo anni dopo seppi perché. Nonno Stalin andava a casa di qualche collega della Fiat che sarebbe stato al Comunale per tifare Juve, così lui se la sarebbe spassata con la moglie. Ho sempre avuto una curiosità: visti i tempi lentissimi che aveva per vestizione e svestizione, e la durata della partita di calcio, Nonno Stalin, che rappresentava sul talamo (altrui) la nostra incrollabile fede granata, avrà fatto sesso vestito o nudo?
Nonno Stalin teneva per sé tutto il salario, ogni sera ci portava due chili di pane e due litri di latte. Per lui, costo zero. Il latte glielo dava la Fiat, perché faceva un lavoro oltre che duro, pure insalubre, come tutti quelli del Reparto 5 (qui venivano mandati i più robusti e gli antifascisti schedati: lui aveva entrambe le caratteristiche, e ne andava fiero), il pane lo otteneva dalla giunonica panettiera, “a gratis”, come si diceva a Torino. Tutte le spese della famiglia erano quindi a carico di papà e di nonna, che oltre al miserevole compenso come portinaia faceva altri lavori, in stagione confezionava i marron glacé per Ghigo, preparava marmellate e concentrato di pomodoro per la drogheria Ferrari, lucidava l’argenteria della gioielleria Ceretto. Nonno Stalin era il classico mantenuto, e come tale si comportava, in scioltezza.
Quando nell’immediato Dopoguerra morì, soffrii per il dolore della Nonna (ne era perdutamente innamorata), meno per lui, perché la faceva piangere. Anni dopo, ascoltando di straforo certi colloqui di mamma con una sua sorella, scoprii che Nonno Stalin aveva tradito la Nonna, ogni giorno, con la camiciaia del piano ammezzato e la panettiera. Capii il perché aveva camicie da ricco, pur essendo un poveraccio, e perché durante i periodi più duri della guerra, dove con la tessera annonaria si portava ben poco in tavola, noi avevamo due chili di pane fragrante al giorno. Dalla guerra tutti uscirono più magri, non noi.
Solo da adulto rivalutai Nonno Stalin. Ricordai la tensione che c’era in famiglia quando il Duce veniva a Torino e lui messo in galera il giorno prima dell’arrivo, usciva il giorno dopo la partenza. In quei momenti si trasfigurava, mostrava una grande dignità, io lo ammiravo e gli volevo bene. Ho ricordi confusi ma vividi del 15 maggio del ’39, quando Mussolini venne a inaugurare Mirafiori, per nostra fortuna fu un colossale flop, che gettò nella costernazione Giovanni Agnelli (papà stigmatizzò la camicia nera esibita dal Senatore, “offensiva per noi operai”, diceva). Il Duce fu sfortunato, quella mattina piovve a dirotto, abituato ad applausi scroscianti dopo ogni frase, non capiva perché applaudivano solo quelli delle prime file (gerarchi), mentre i 50.000 operai rimanevano silenziosi a braccia conserte (papà aveva in bella vista la fede in oro all’anulare, che si era rifiutato, con mamma, di donare alla Patria). La credibilità di Mussolini nella Torino operaia era zero, nessuno dei suoi informatori aveva osato dirgli come lo chiamavamo: Monssù Ceruti, ch’a lu fica ’cul a tüti. Negli anni successivi, varie volte si sparse la voce che stava per tornare, Nonno Stalin, diligente, si presentava al Commissariato con la sua valigia di cartone, ma salvo una volta, per un errore, mai più andò agli arresti preventivi; diceva, “Monssù Ceruti ha paura di noi operai”. Nonno Stalin fu un pessimo marito, un comunista da operetta, ma un vero antifascista.
La rivalutazione di Nonno Stalin da parte mia fu totale, seppur tardiva, quando nel 1999, grazie a Pietrangelo Buttafuoco (e al Foglio), un Norberto Bobbio novantenne (era della stesso millesimo di mamma), confessò (era ora) di essersi rivolto a Benito Mussolini per ottenere un avanzamento di carriera e di essersi vergognato per tutta la vita di ciò. In quel momento, il Papa laico dei loschi “azionisti”, degli antifascisti d’accatto, cessò (era ora) di essere un maître à penser e Nonno Stalin, almeno per me, lo sostituì nel Pantheon degli antifascisti.
I comizi politici a tavola dopo cena, contro il Duce e a favore di Stalin, che per far piacere a nonna paragonava a Gesù
Preso da un attacco di revisionismo storico, volli allora approfondire l’altro aspetto curioso della sua vita, le donne. Dedussi come la Natura si fosse distratta mentre assemblava il suo cervello, forse per farsi perdonare, debordò sul fisico. Scoprii che Zio Michele (zio di Nonno Stalin, che lui considerava il padre sognato) era stato un grande amatore di contadine, operaie di filanda, vedove di possidenti, si sussurrava pure di una badessa, e che fossero tutte pazze di lui.
Il profilo che ne emergeva era quello, uso una locuzione imparata nel Caribe, di un “tiguere”, il macho superdotato, vanitoso, di ambizioni smisurate, a cui si perdona tutto, perché depositario di un’arte antica, sopraffina, che non si impara, ma si possiede per natura, quella di utilizzare le donne, per la propria scalata sociale. (Porfirio Rubirosa, per intenderci). Zio Michele tentò il grande colpo con la giovane figlia di un nobiluomo, la mise incinta e attese gli eventi: non andò come lui sperava, la fanciulla fu deportata in convento, un giorno lo ritrovarono massacrato di botte. Sopravvisse, ma fu per sempre sciancato. Per alcuni anni si trascinò da casa all’osteria, un giorno pulendo un vecchio fucile da caccia partì un colpo di fucile che lo uccise.
Teneva per sé tutto il salario, ogni sera ci portava due chili di pane e due litri di latte.
Il latte glielo dava la Fiat, dove lavorava
Invece, Nonno Stalin, suo degno successore, verso l’esterno gestì bene questo suo ingombrante “lui”, con nessuno si confidò dei suoi successi amorosi, anzi negò sempre qualsiasi coinvolgimento con le donne, giurava di essere fedele alla Nonna.
Trent’anni dopo Moravia scrisse un libro che riprendeva il rapporto che Nonno Stalin aveva instaurato con il suo “lui”, certo un dialogo continuo, ma alla fine faceva ciò che “lui” voleva.
Nonno Stalin ebbe due grandi intuizioni: farsi migrante (chapeau!) e abbandonare l’agricoltura per l’industria (chapeau!). Prima andò in Francia (papà nacque ad Apt, in Provenza) poi a Torino (Fiat). Dopo le avventure di Zio Michele e di Nonno Stalin, noi Ruggeri capimmo che il riscatto sociale della nostra famiglia era rimandato, comunque la modalità non poteva essere quella di puntare tutto sul sesso, dovevamo inventarci qualcos’altro.
Molti anni dopo, scegliemmo il management (il Ceo ha molte comunanze con il “tiguere”). Ci andò bene. Nonno Stalin avrebbe apprezzato, avrebbe indossato le amate scarpe bicolore di cuoio grasso, e festeggiato.