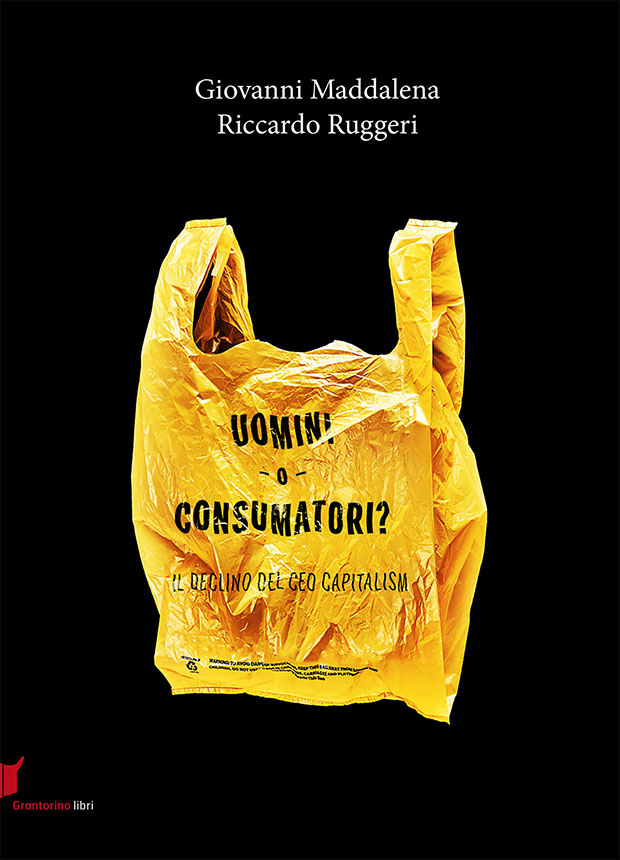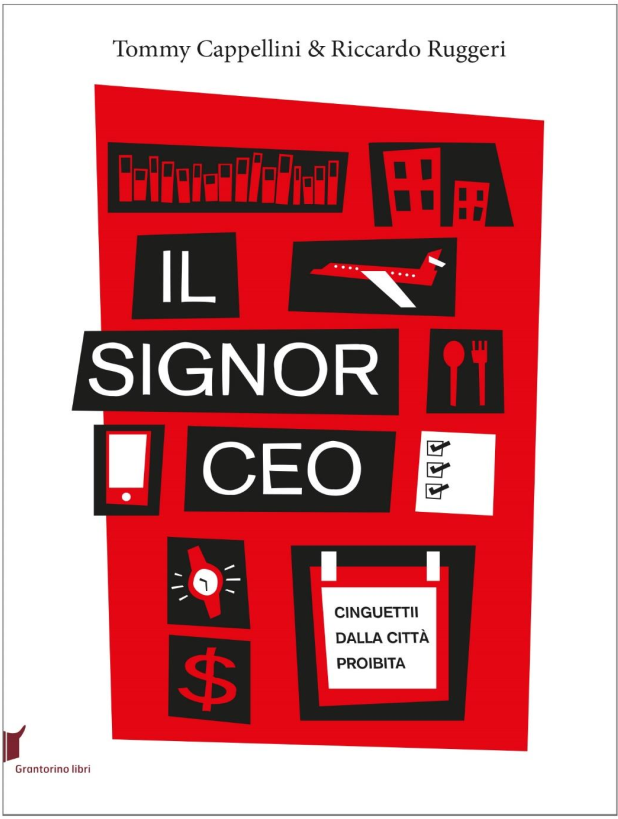Fra un paio di mesi, Donald Trump sarà insediato, 45° presidente degli Stati Uniti d’America. In quei giorni uscirà, da Marsilio, un libro sulla «mia» America, il racconto scanzonato e sofferto di un viaggio a zigzag, durato 40 anni, di un comune cittadino del mondo. Gli ultimi zigzag li ho dedicati al prima e al dopo elezioni, quella che ha portato l’imbarazzante The Donald alla presidenza, in luogo della corrotta The Hillary.
Come succede da sempre in America, la vittoria di uno dei due candidati dipende dal mix di elettori che in ognuno dei 50 Stati decide di andare o no a votare, un mix sempre diverso a ogni elezione. Tutti gli analisti hanno convenuto che c’è un solo sconfitto: la classe dominante dem-rep (il Partito della Nazione). Questi devono prendere atto che la loro leadership è a fine corsa. Alcuni loro figli ideologizzati che spaccano vetrine, imbrattano muri, da fighetti si fanno naziskin, lo confermano.
Il mitico «che fare?» di Lenin si impone, il dilemma è: buttare questo capitalismo deviato o difenderlo? «Buona la seconda!», rispondono ilari. La loro mente malata sputa: «In una democrazia in crisi, il voto è ancora necessario?». La risposta è già contenuta nella domanda: «Via il maledetto suffragio universale». Per supportarli sono già pronti, con i loro libri, due studiosi prêt à porter. Il filosofo politico americano Jason Brennan ha licenziato Against democracy, appena uscito per Princeton University press, e il poeta-scrittore belga David Van Reybrouck, nel suo recente Contro le elezioni (Feltrinelli), offrono un basket di ricette suggestive sul tema.
Il primo propone l’epistocrazia: vota solo chi ha un livello culturale elevato, oppure votano tutti, ma i voti vengono «pesati» in base al reddito-titolo di studio, le vecchie teorie sette-ottocentesche, alla John Stuart Mill, per intenderci. Il secondo, più radicale ma meno fascistoide, sostiene che bisogna rinunciare al voto popolare e sorteggiare le cariche pubbliche sul modello Aristotele («Uno dei tratti distintivi della libertà è essere, a turno, governati e governanti»). Immaginiamoci le truffe nei sorteggi!
In questo quadretto non può mancare il peggio del peggio dell’umanità colta, i nuovi sovrani digitali, che invece hanno idee chiarissime e le stanno da tempo portando avanti, attraverso l’annullamento delle mediazioni di tutti gli altri, salvo loro. Perché solo loro? Perché sono gli unici gestori, dicono, della knowledge economy, solo loro posseggono piattaforme che manipolano immensi archivi di dati affidabili, di testimoni remoti, di interpreti specialistici, cioè il software sovrano, indispensabile per prendere le decisioni alte. Sostiene Eric Schmidt (Google) che il riferimento non possono essere politici corruttibili dalle lobby (sic!), ma loro di Google, «scienziati che cercano di creare uno specchio virtuale e sempre aggiornato del mondo». Mutatis mutandis, è l’idea del Parlamento Zuckerberg, la piattaforma Facebook dove 1,5 miliardi di umani (ma potrebbe contenere tutti noi 7 miliardi di umani) conversano all’infinito di qualsiasi tema senza conoscerne nessuno, creando un’eco perenne di suoni (sordi). Ma al contempo, e qui sta la chiave di lettura, misurare ogni istante e atomo dei nostri istinti-desideri, e rivendere, banalmente, queste informazioni per offerte commerciali personalizzate, per renderci sempre più zombie.
Mi sfugge perché si vogliano cavalcare modelli fascistoidi o semplicemente ridicoli, quando a portata di mano c’è il modello democratico svizzero: una confederazione a tre livelli, legge elettorale proporzionale, annuali referendum popolari senza quorum. Nei periodi di crisi, come probabilmente sarà l’intero XXI secolo, la rappresentatività deve tranquillamente prevalere sulla governabilità: la pace sociale è la priorità. Abbiamo bisogno di più politica, di meno deleghe. L’aspetto curioso è che sarebbe proprio quello il modello che permetterebbe alle élite politiche attuali di rimanere al potere, pur con certi vincoli. E quello che più si avvicina a un modello liberale mite, nel quale mi piacerebbe vivessero i miei nipoti.
Riccardo Ruggeri