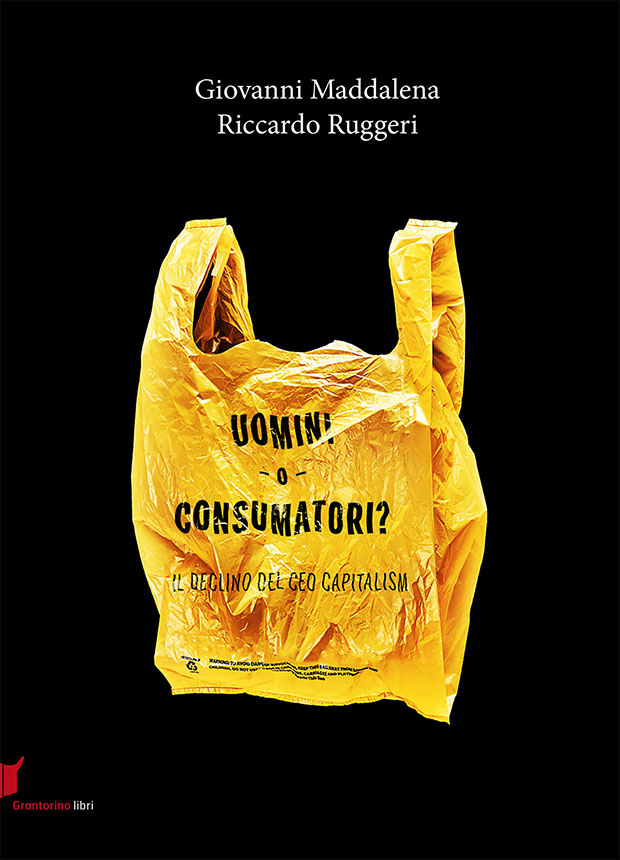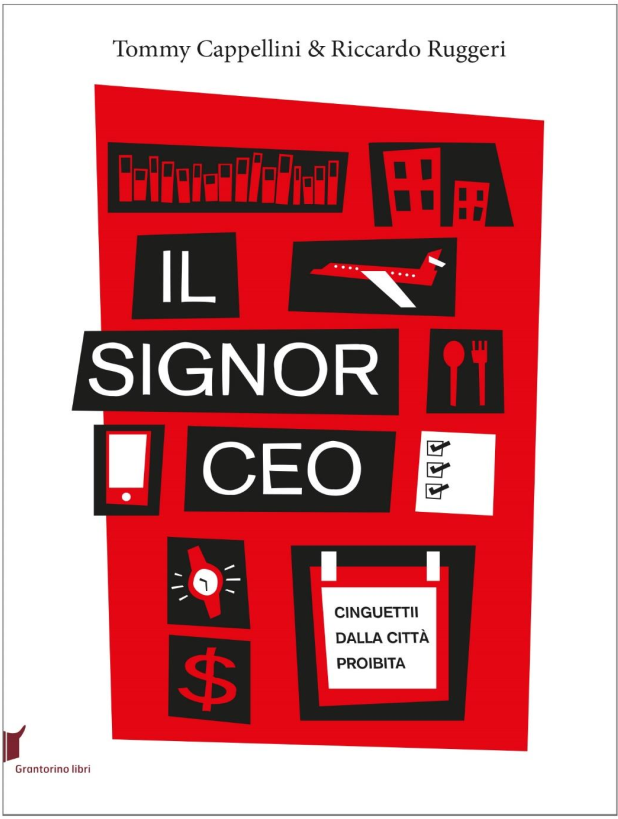Mi sono stufato del Job Act, sia chiaro solo in termini di comunicazione. Nessuna intenzione di criticare, non sarebbe questa la sede e non sarebbe neppure giusto, è troppo presto, è ancora un bambolotto, succhia il latte, giudichiamolo alla fine del triennio. Come succede spesso, certe leggi sono o sopravvalutate o sottovalutate. Nel caso del Job Act non c’è dubbio che il suo impatto su tutta la problematica del lavoro sia stato sopravvalutato, volutamente o meno non lo so. Il Job Act, al di là del nome idiota, gli italiani o lo hanno amato o odiato da subito, perché eliminava l’art. 18, un pezzo (infimo ma emblematico) dello Statuto dei Lavoratori, molto chiacchierato da sempre, giudicato osceno (per i colti), irrilevante (secondo altri, fra cui io che nella mia lunga carriera l’ho incontrato appena tre volte!), sacrosanto (per i sindacati). In realtà, secondo me, il Job Act è una legge-scommessa, il Governo ha deciso di rischiare dei quattrini (tanti, sotto forma di esenzione contributiva, pare 10 miliardi all’anno per tre anni, ovviamente a debito) nella speranza che si innescasse un processo virtuoso, tale da ricuperare l’investimento e conseguente goloso dividendo politico. Lo stesso giochino del Quantative Easing di Draghi, un migliaio di miliardi per portare l’inflazione al 2%. Risultato 0,2%, obiettivo sbagliato del 90%. Classe dirigente curiosa l’attuale, ottusamente passa il suo tempo a cercare di innescare (è il loro verbo) la mitica crescita consuntivando solo flop, ma ottusamente insiste. Finora, come giocatore delle tre carte il compassato Draghi supera il disinvolto Renzi. Una nota a margine, in medicina le sindromi incurabili hanno nomi tedeschi, in economia le ricette più fallimentari hanno nomi inglesi. Questa del Job Act è una modalità markettara che molti di noi (io tra questi) hanno spesso adottato nel business, se scatta sei un genio, se fallisce sei un idiota, in realtà sei uno scommettitore, a volte sfigato, a volte no. Dipende da come la vendi al tuo azionista, se come scommessa tutto bene, se la vendi come ricetta, la paghi cara.
Sugli indici dell’occupazione preferisco rimanere defilato, Istat considera occupato anche chi lavora almeno un’ora alla settimana, roba da scherzi a parte. Mi parrebbe più logico fare le statistiche ragionando non a “cranio”, ma a “ore lavorate settimanalmente”; così risali al numero vero degli occupati. Consiglio di non farlo, sarebbe un dramma politico-comunicazionale per i politici, per i media, per i nostri partner, anche se fotograferebbe la situazione reale dell’occupazione. Un fallimento cosmico. Di questi temi tutti ne scrivono, tutti ne dibattono, tutti pontificano, io mi fido solo del professor Luca Ricolfi, splendido un suo intervento tempo fa a Federmanager, passato sotto silenzio, immagino perché toccò un nervo scoperto dello storytelling renziano, sottolineando come, nonostante il Job Act, al netto delle riconversioni dei contratti in essere, nel 2015 il numero dei nuovi occupati saliva a un tasso inferiore rispetto al tempo del Governo Letta (sic!), figuriamoci ora. Mi fido pure dell’economista Francesco Pontelli di Mestre, focalizzato su “abbigliamento, tessile, calzaturiero”, un settore che considero strategico per il paese.
Intorno al Job Act si è creata una chiassosa campagna comunicazionale, che chiamare “aria fritta” non sarebbe elegante, più corretto “aria tiepida”.