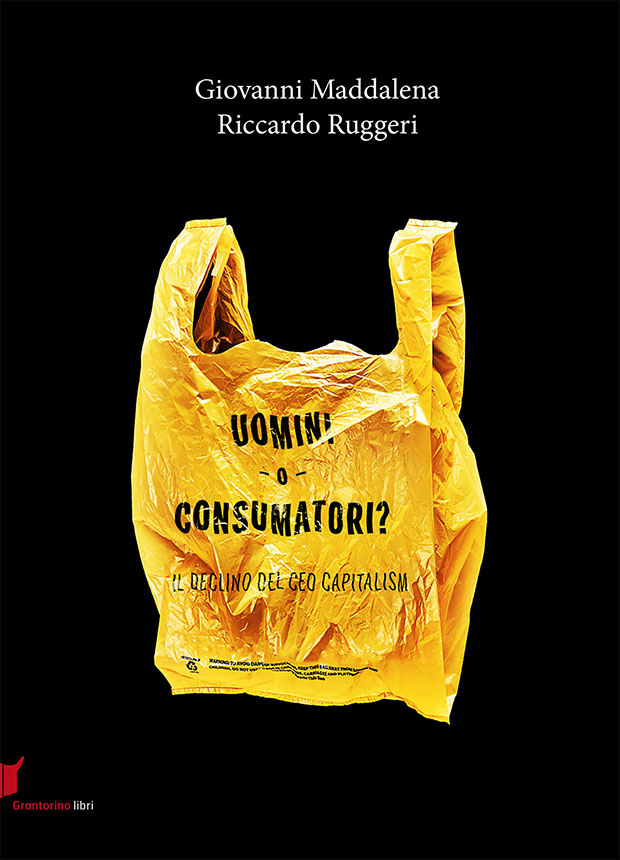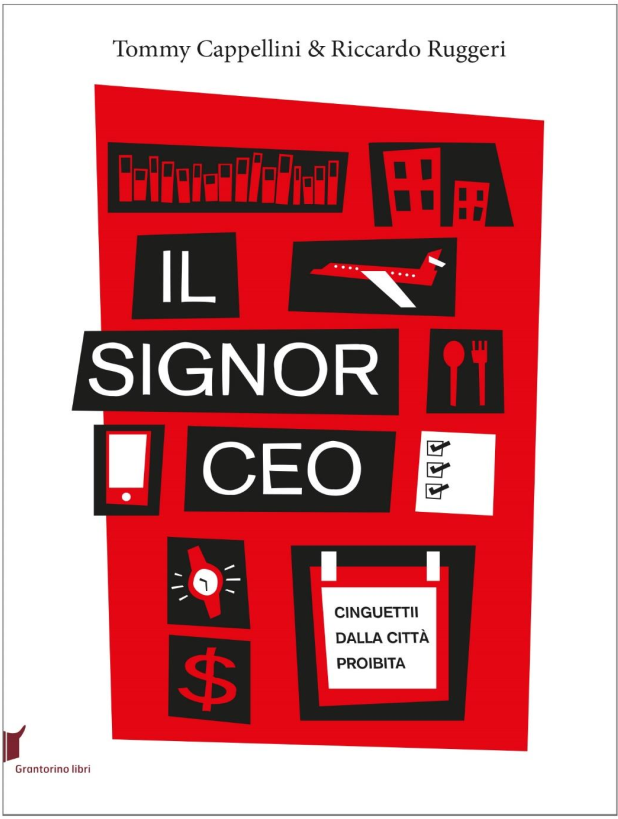Ho licenziato per la stampa (Marsilio) un libro (America. Un romanzo gotico. Cartoline da un impero in crisi) al quale ho lavorato dallo scoppio della crisi del 2008: uscirà l’11 maggio. Ho avuto il privilegio di nascere alla metà di un terribile decennio (gli anni Trenta); alla domenica mio papà leggeva alla mamma Furore di John Steinbeck, di certo non aveva visto le foto di Dorothea Lange e Walker Ewans che raccontavano l’impoverimento dei mezzadri, i linciaggi che nel sud e nel Midwest quadruplicarono di numero e di intensità, il razzismo latente che si palesò senza più pudore. I numeri erano impietosi, dall’ubriacatura della ricchezza (cartacea, a debito) degli anni Venti (simile a quella finta che oggi ci raccontano i media di regime), il reddito annuo delle famiglie precipitò del 40%, la produzione industriale scese del 45%, il valore delle azioni fu decurtata del 90%.
Il parallelo con la crisi di oggi è più sottile nelle manifestazioni esteriori, ma resta identico il senso di disperazione e di incertezza. Sono le due parole chiave che connotarono quel periodo, e pure l’attuale: disperazione e incertezza.
La Royal Accademy di Londra ha avuto la geniale intuizione di fare, su quel decennio (gli anni Trenta), che condizionò poi l’intero Novecento, una mostra: America after the fall, 45 quadri di 32 artisti, dipinti fra il 1929 e il 1941. La reazione degli artisti di allora alla grande depressione anticipò quella dei cittadini, come sempre avviene nei grandi cambiamenti: guardando al passato e al futuro, all’industria e all’agricoltura, al centro delle città e alle periferie, al proprio paese e al mondo.
Le nostre periferie di oggi ricordano il quadro di Joe Jones American justice il racconto di un linciaggio, tipo quello di Alatri, non filtrato dalle cineprese di sorveglianza. E ancora, Paul Cadmus (The fleet is in! del 1934) racconta le serate di marinai ubriachi, puttane e gay (Cadmus era gay) ma fa il paio con le volgarità e le follie che vediamo nelle movide dei nostri fine settimana, e ogni giorno sulle nostre strade. Ogni quadro coglie un aspetto di quel viaggio all’inferno, spesso senza ritorno, di quel decennio. New York movie (1939) di Edward Hopper, chiude il cerchio, coglie il tentativo estremo di nascondersi nel buio di un cinema per ritrovare uno straccio di conforto alla propria vita, capisci che sta precipitando, ma non puoi fare nulla. La scena è pervasa da una ferocia psicologica imbarazzante: sala semivuota, una maschera (bionda) assorta nei propri pensieri, il film che scorre sullo schermo, l’unica spettatrice, occhi semichiusi, il mento appoggiato sulla mano, è disperata, prende atto che non c’è, per lei, alcuna via di fuga.
Tutti, cittadini e artisti, e pure la politica con Roosevelt, parteciparono all’elaborazione politica, economica e culturale della depressione, privata e pubblica, consci della gravità della situazione. Poi (bisogna dirlo), grazie alla guerra, l’America, di slancio, superò la Grande Crisi, e si fece Impero. Il suo “modello”, profondamente modificato nella sostanza e nella forma, non solo sopravvisse, ma eliminò l’altro modello, quello sovietico. Le modifiche apportate (meglio, non apportate) trent’anni fa hanno avuto vita breve, da dieci abbiamo perso la bussola. Nulla elaboriamo, nulla facciamo, difendiamo un modello in crisi progressiva, uno stile di vita spossato ci accompagna, ci ritroviamo culturalmente nudi, nelle mani di una banda di giovani idioti che vogliono dominare il mondo con le loro piattaforme e le loro app. Con il cervello di una gallina e la superbia dei pavoni che si ritrovano stanno facendo solo danni. Siamo tornati al 1902, al Lenin di “Che fare?”.
Riccardo Ruggeri