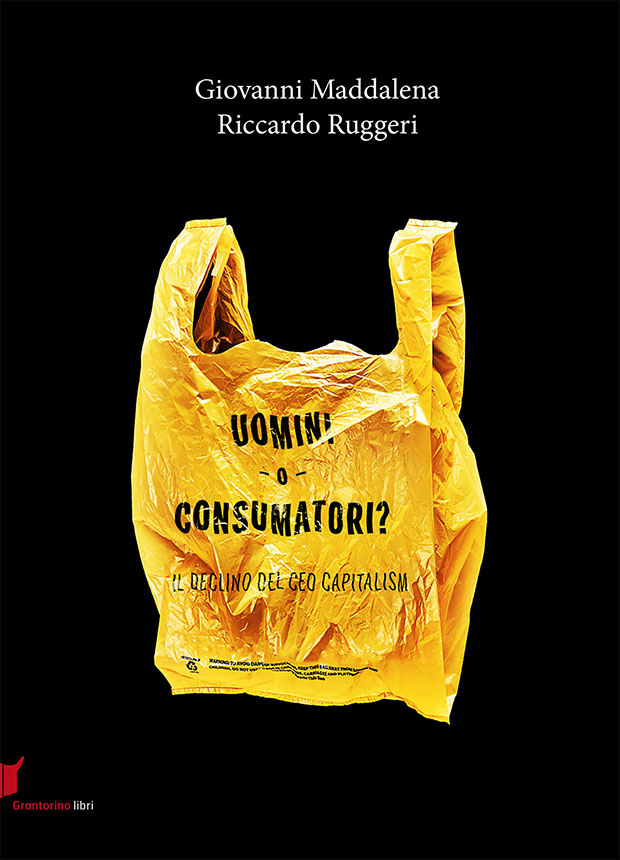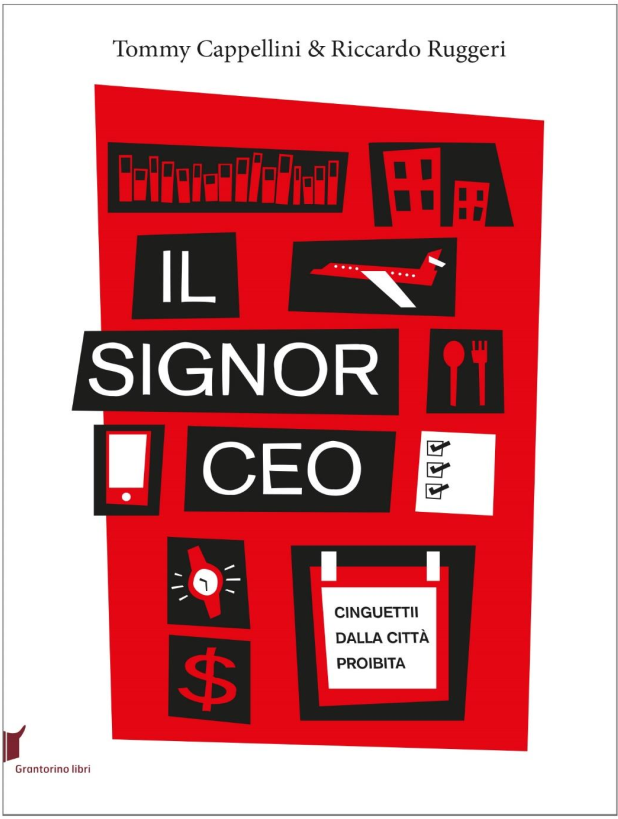E’ ormai passato oltre un anno da quando, inopinatamente, Donald Trump è stato eletto. Qualcuno di noi, accademici, giornalisti, cittadini comuni può, in onestà, dire di avere capito che leader sia costui? Certo, un europeo colto o un americano liberal lo bollerebbe come un buzzurro, e non sbaglierebbe, un italiano della sinistra dei quadrilateri, con la puzza al naso e la bocca a culo di gallina, lo paragonerebbe al primo Silvio Berlusconi, e sbaglierebbe. Perché Berlusconi aveva l’ambizione di cambiare il paese dall’interno dell’establishment, non per nulla si dice che avesse sul comodino una foto di Gianni Agnelli (il quale a sua volta teneva nel suo studio una curiosa foto: una carica della polizia polacca degli anni Trenta contro un corteo operaio).
Trump no, lui era un cittadino medio americano diventato ricco (neppure molto, infatti ha sempre mentito, per eccesso, sul suo patrimonio) e tale è rimasto, e vuole sovvertire l’establishment, non solo in termini politici, ma culturali (questo li rende furibondi). Lui il problema di cambiare atteggiamenti non se lo pone, lui si piace così, e sa che i suoi elettori così lo vogliono, e appena sgarra lo castigano: vedi la sberla che gli hanno dato nella scelta del candidato repubblicano alle primarie senatoriali dell’Alabama.
Quando ho scritto il libro “America, un romanzo storico” uscito pochi mesi fa per Marsilio, raccontavo come l’America si stesse spaccando in due, persino in termini territoriali. Il problema dell’America è che i nodi di un quarto di secolo di presidenze sciagurate (Clinton–Bush–Obama) stanno arrivando al pettine. Il combinato disposto ceo-capitalism–polically correct ha creato una spaccatura sempre più profonda nel paese, non solo di tipo sociale, ma culturale, che ormai sfocia nel territoriale. Le città delle coste est e ovest (finanza e piattaforme digitali) da un lato, il resto (l’America vera) dall’altro. La seconda è rimasta America l’altra sta diventando un territorio di tipo anseatico, ricco di una serie di logge cosmopolite.
I fighetti del New York Times lo odiano visceralmente, pur di abbatterlo dedicano alla sua demolizione 106 giornalisti; incredibile ma vero, uno è stato assunto per essere sul pezzo alle 5 del mattino, pronto a “analizzare-demolire” il famoso “The Six Tweet” di Trump, una specie di sputo comunicativo che si palesa in rete intorno alle 6, random come i piattelli lanciati nella disciplina olimpica del tiro. Non hanno ancora capito che per lui Twitter è un mezzo per essere costantemente connesso con i suoi elettori, indica gli obiettivi, le pre decisioni, spiega come le colpe dei suoi insuccessi siano da imputarsi ai dem., all’establishment, alla Cina, all’Iran. Mai nessun leader aveva condiviso le sue sconfitte, a volte in modo preventivo, con gli elettori, come sta facendo lui, anzi più viene sconfitto più monta la rabbia dei suoi verso i suoi nemici. E più lo rispettano perché lui, appena sveglio si rivolge a loro, “the six tweet” è la loro sveglia, l’alba di un nuovo giorno in cui sanno che devono correre a perfidiato nella savana per sfuggire al losco establishment liberal.
In Europa abbiamo sorriso sulla violenza verbale di Trump verso le stelle del Football per il loro comportamento verso l’inno nazionale. Lo sdegno di Trump è stato condiviso dai suoi elettori, riducendo il favorability rating della National Football League di 40 punti (sic!) e gli spettatori, cioè i ricavi, del 20% (sono miliardi di $). Un’altra istituzione dell’establishment smascherata, e un’altra frattura nella società americana si approfondisce.
Come studioso di America ho capito solo ora la genialità di Steve Bannon, e lo slogan che campeggiava nel suo ufficio quando guidava la campagna elettorale: “Let Trump be Trump”. Bannon ha sempre lasciato che Trump facesse Trump, perché Trump non è modificabile, come non lo è il cittadino medio americano legato ai suoi valori. In appena un anno il valore aggiunto della presidenza Trump alla comprensione di dove stia andando il mondo occidentale, in termini culturali è stato determinante.
Ecco cosa dice David Rohde (New Yorker) dalla sua redazione (fighetta) al 38° piano del nuovo World Trade Center: “Trump ci chiama fake news e, e in base al primo emendamento, può farlo. Ha buone chance per riuscire, a modo suo, a dimostrarlo”. Ma David si guarda bene dall’ammettere che la loro informazione è stata ed è, senza ombra di dubbio, fake, anche se si nasconde dietro la locuzione consolatoria “noi media abbiamo un ruolo cruciale nel mantenere sana la democrazia americana”. Quelle che loro chiamano “frustrazioni e paure della gente” sono il risultato del ceo capitalism vincente delle Big Five, che per aumentare il mercato e abbattere i costi, ha distrutto “l’ascensore sociale”, la grande invenzione liberale che dava a ogni americano la chance (potenziale) di diventare ricco. Sono costoro che hanno tradito, per volgari interessi di bottega, l’idea liberale. E sull’ascensore sociale la guerra élite-popolo sarà totale, non possono esserci prigionieri: o costoro saltano o quello americano sarà un popolo di zombie (e così l’Occidente).
E’ ciò che sta succedendo in Italia, il possesso del territorio diventa cruciale, il centro destra (popolare) si sta impossessando dei territori del centro nord, le élite si auto confinano nei “quadrilateri” delle città (“Milano Centro è Europa! Il resto è Italia”, si compiacciono i meschini, senza capire che si stanno evirando) e difendono le ridotte del sud affidandole a cacicchi prezzolati. Anche noi ne vedremo delle belle.