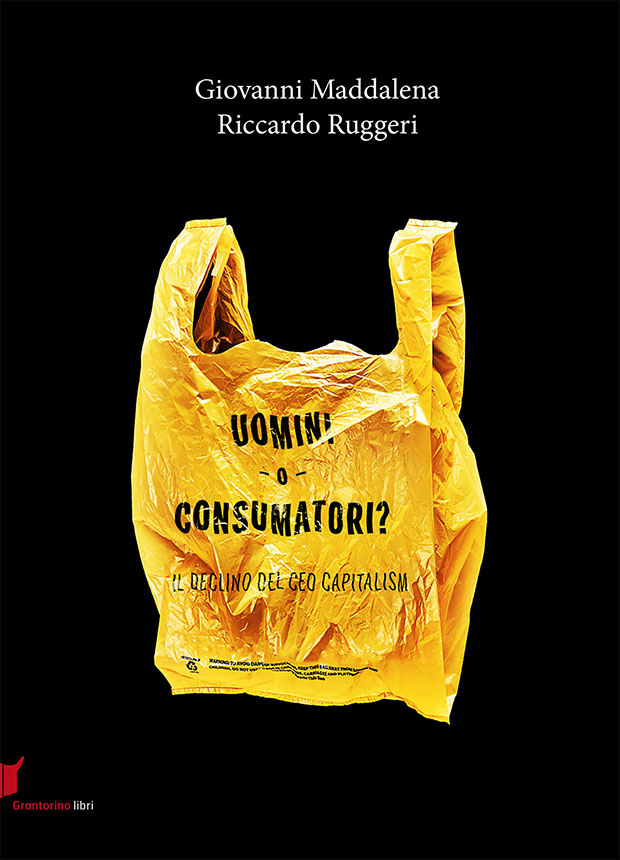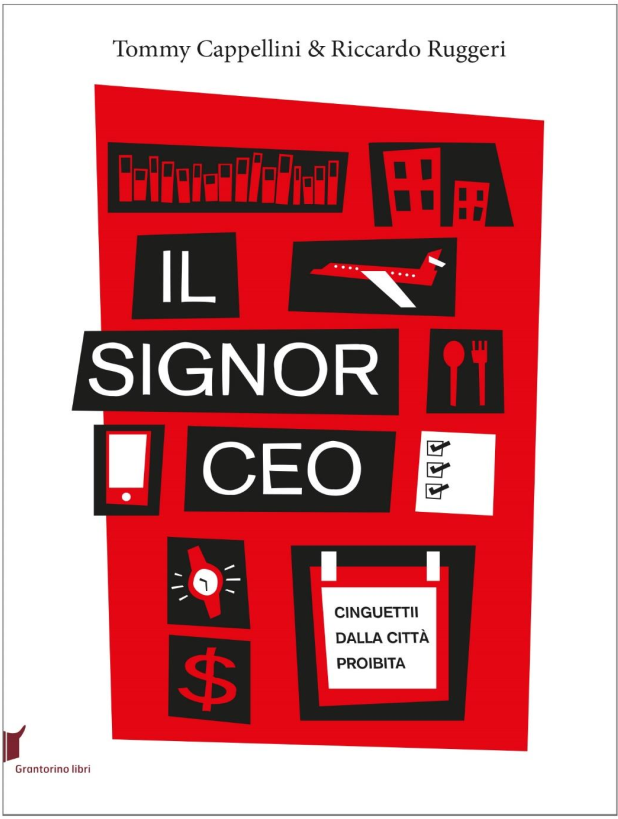Chi, come me, lavorava a Londra ai tempi della Signora Thatcher regnante, aveva assistito in diretta al salvataggio politico, economico, morale, del Regno Unito, ammirandola (da ex operaio il mio giudizio positivo valeva doppio), che ha poi subito l’inettitudine strutturale di David Cameron (un Obama inglese), ora non può che aggrapparsi a Theresa May e chiedersi “saremo a fine corsa?” Niall Ferguson, l’unico che abbia analizzato in profondità il discorso di May al congresso dei conservatori di Birmingham, si chiede: “sono finiti i trent’anni (1979-2008) di sfrenata globalizzazione e della sua ancella, la tecnologia dell’informazione?” Aggiungo io, è stata l’epoca dei mercati globalizzati e drogati, mutuando Trump, dell’erezione continua, con stupri osceni delle classi medie e povere. Trent’anni nei quali “noi élite abbiamo pasteggiato a caviale e a champagne, parlavamo tre lingue, avevamo tre case, curiosamente nessuna nel luogo in cui eravamo nati”. La “festa è finita”, amava dire Gianni Agnelli, a volte ci imbroccava. Non c’è dubbio che questi trent’anni siano finiti, di più, stanno marcendo, se non ci affrettiamo a gettarvi calce viva, porteranno pure noi nella tomba. Ci voleva una donna (Chapeau!), ci voleva il partito conservatore per eccellenza, quello inglese (Chapeau!), per prendere atto del fallimento, non certo del modello liberale, ma della sua versione illiberale delle banche d’affari di Wall Street e delle losche corporation di Silicon Valley, dei regolatori dal piglio militare, dei politici riconducibili ai G7. Tre i concetti che la Signora May si è impegnata a declinare nel dopo Brexit, eccoli: “1 Dovremo mettere il Governo al servizio della classe lavoratrice; 2 Lo Stato esiste per offrire ciò che i mercati non sono capaci di offrire; 3 Dovremo individuare le aziende industriali di valore strategico e sostenerle con idonee politiche, di ricerca e sviluppo, commerciali, fiscali, infrastrutturali”. Insomma una politica thatcheriana al servizio del lavoro, l’unica priorità di quest’epoca sghemba. Ormai è chiaro, l’uberizzazione del lavoro impostoci ha un materiale di risulta certo: il lavoro diventato e trattato da commodity, scomparsa della classe media, lavoratori disoccupati, precari, infine zombie, grazie al reddito di cittadinanza. E’ di due giorni fa la sentenza del Central London Employment Tribunal che impone a Uber di assumere i 30.000 driver che scorrazzano per Londra, perché “sono lavoratori che non lo fanno per gioco ma per vivere” (magistrale ironia inglese). Grazie alla loro magistratura e a Theresa May gli inglesi, dopo l’ubriacatura della gig economy, riaffermano uno dei principi sui quali poggia la filosofia dell’ascensore sociale: non si lavora per hobby, ma per avere una vita dignitosa. Il capitalismo liberale deve essere preservato da una banda di teppisti digitali. Un’informazione di servizio per i lettori: non chiamerò più costoro “felpe californiane”, avendole loro abbandonate, sostitute da “gilet di pile” (è un tessuto tecnologico, ndr). Dopo il discorso di May mi chiedo: siamo vicini al fine corsa, al momento della verità? Che poi avvenga fra un anno o dieci poco mi importa, l’importante è il trend, come lo è questa sentenza, in fondo ovvia. Chiediamoci invece se noi élite saremo capaci di una feroce autocritica, chiedere scusa al popolo per le ricette propinate loro in questi ultimi trent’anni, rottamare tutta la classe dirigente ora al potere. La cultura dell’errore non l’abbiamo ancora chiara, ci fa velo l’infinita arroganza nella quale ci rotoliamo nelle nostre ideologie. E’ dalla cultura dell’errore che bisogna passare se si vuol crescere veramente, come popoli, come civiltà.
Su noi italiani, per una volta tanto sono ottimista, di tutti gli altri popoli occidentali siamo i più fortunati, non dobbiamo neppure modificare la Costituzione, basta applicare l’articolo 1, una Repubblica fondata sul lavoro. Tutto il resto è fuffa.
Riccardo Ruggeri