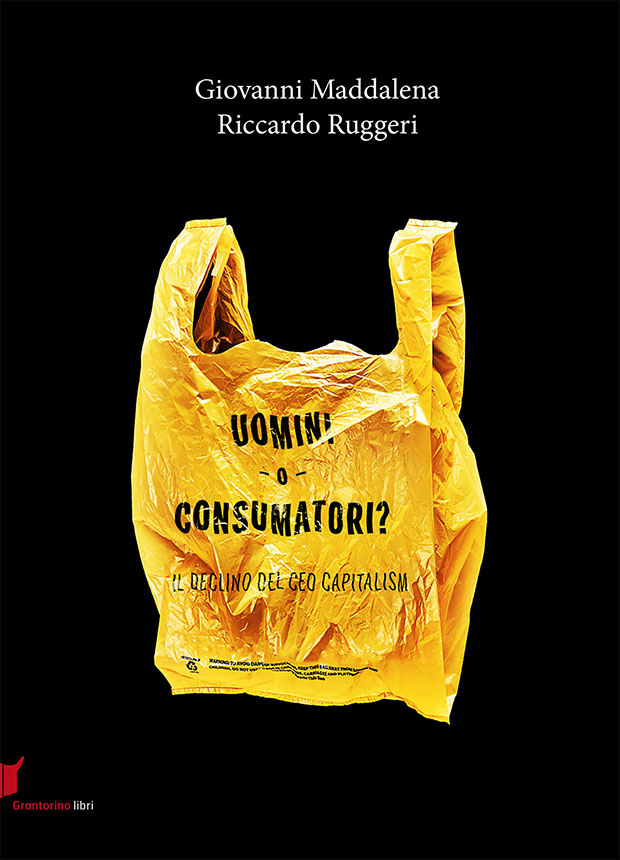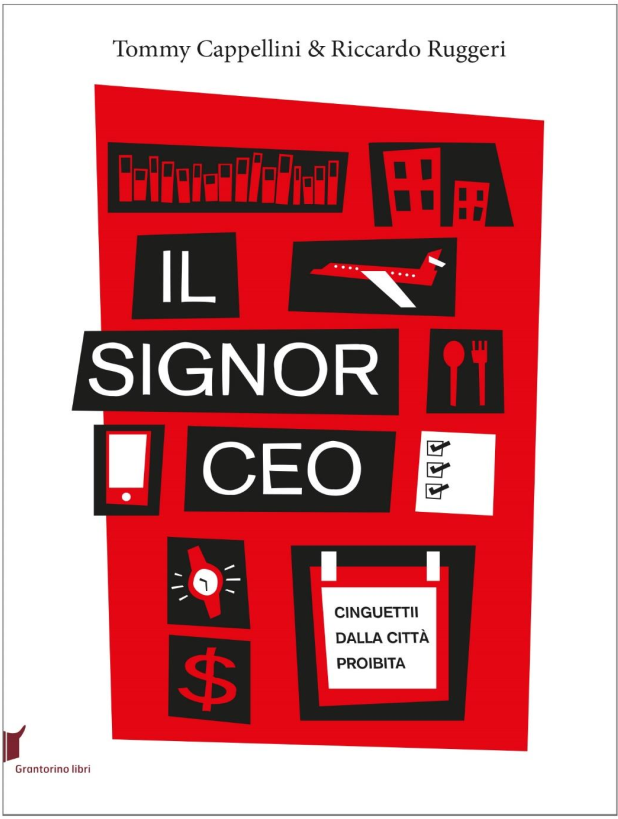Sabato sera ho visto Sanremo, domenica ho letto il pezzo di Eugenio Scalfari su Repubblica, lunedì mattina mi sono centellinata sul Corriere della Sera l’intervista a Piercamillo Davigo sui 25 anni trascorsi da Mani Pulite, lunedì pomeriggio ho trascorso cinque ore, in streaming, con i vertici del Pd su La7 . Quarantotto ore passate a osservare un mondo che stava precipitando nella storia.
Ho assistito in diretta alla morte dell’unico partito sopravvissuto a Mani Pulite. Scalfari, con il suo pezzo (Rifondare la sinistra per battere il pericolo populista), forse l’aveva intuito, l’articolo era un meraviglioso affresco, dove c’era tutto: l’Europa come dovrebbe essere, l’America com’era con Obama e lo sarebbe stata con The Hillary, e curiosamente non lo sarà più solo perché la maggioranza (ignorante, e pure bianca) degli americani ha eletto Donald Trump (questa l’analisi, poi ripetuta, in modo più sfumato, da Matteo Renzi). Il pezzo era percorso da un soffuso profumo d’ulivo, aveva un tratto romantico, ricco di pathos, con un’unica carenza, non si poneva la domanda chiave: il nuovo Ulivo dove troverebbe i voti? La sintesi l’ho fatta su Twitter: “grande affresco domenicale di Scalfari, funzionerebbe se non ci fosse quel maledetto suffragio universale”. Ormai il problema di quelli di sinistra, riformisti, liberisti, liberal, partito della Nazione, classe dominante, élite, è uno solo: il popolo non li vota più, a prescindere direbbe Totò. Questi, anziché prendere atto del loro fallimento, insultano i potenziali elettori con epiteti volgari come populisti, xenofobi, gufi. Chi cederà?
La Direzione del Pd è stata un momento alto, in termini non solo politici, ma umani, quello che restava del grande sogno moroteo e berlingueriano di unire le forze riformiste della sinistra dc e del partito comunista in un nuovo sol dell’avvenire si è chiuso, forse per sempre, in una giornata grigia, ricca di polveri sottili, di umido smog. Quelli che si succedevano sul palco capivano che era un momento storico (il volto livido di Piero Fassino era la rappresentazione plastica della disperazione), sono stati tutti educati, civili, composti, come si conveniva a un funerale. Sì, ieri si è preso atto che il Pd era morto, il tentativo (disperato) di tre anni fa dello sciamano Matteo Renzi era finito il 4 dicembre 2016. I settanta giorni trascorsi da allora mi hanno ricordato la fine di Francisco Franco: il generalissimo era tecnicamente morto, passava gli ultimi giorni ad assopirsi davanti alla tv guardando le partite della Liga e mendicando dall’infermiera un ultimo trancio di foie gras.
Sul palco si è succeduto il meglio della classe dirigente del Pd, sono stati tutti patetici, ma nel significato alto della parola, lo sono stati in modo toccante, una grande dignità è stata la cifra della giornata. Un funerale, certo, ma l’estinto era stato amato e stimato da tutti, non possedeva ormai più nulla, quindi gli eredi erano sereni, ci si poteva spartire solo il dolore, e questo era sincero. Ora ognuno andrà per la sua strada, gli uni svolteranno a sinistra, gli altri svolteranno a destra, raccatteranno gli ultimi berlusconiani e si metteranno in cammino (mi ricordano il post apocalittico The Road di Comac McCarthy).
Il Pd-Ulivo era nato come un organismo geneticamente modificato, creato in laboratorio da due professori (Arturo Parisi, Romano Prodi), rimasto tale fino a quando il collante (Berlusconi, versione Arcore) lo ha tenuto insieme, riappiccicato da Renzi (Berlusconi, versione Nazareno). Con la fine del Cav. (di lui ormai c’è solo più la “roba”, un manipolo di colonnelli invecchiati, amici e ammiratori che gli vogliono bene) si è spento.
Ieri ho avuto il privilegio di assistere, in diretta, alla morte di “un partito nato morto”, secondo la geniale definizione d’epoca di Massimo Cacciari. Lo confesso, mi è apparso nonno Giovanni, comunista targato Livorno, e mi sono commosso.
Riccardo Ruggeri